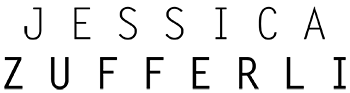Intervista a Gabriele Galimberti – “Locked in Beauty”
Locked in Beauty è il progetto fotografico realizzato da due fotografi documentaristi di fama internazionale, Paolo Woods e Gabriele Galimberti, in mostra al festival Cortona On The Move.
Con il suo contributo ha dato ulteriore concretezza a The COVID-19 Visual Project. A Time of Distance, la piattaforma online il cui obbiettivo è di costituire un archivio permanente e in continuo aggiornamento sugli effetti della pandemia da coronavirus nel mondo.
Nel corso del festival internazionale di visual narrative a Cortona, ho avuto l’opportunità di incontrare Gabriele Galimberti, fotografo e giornalista italiano, nato e cresciuto in Toscana. Sono sempre stata affascinata dai suoi lavori, soprattutto quello degli ultimi dieci anni. Dopo essersi formato come fotografo di moda, ha deciso infatti di iniziare a raccogliere ritratti e storie di persone in tutto il mondo, narrando le loro peculiarità e differenze. Inevitabilmente questa scelta lo ha portato a viaggiare spesso per effettuare reportage e servizi, i quali vengono pubblicati poi su testate italiane e internazionali molto importanti, tra cui National Geographic, The Sunday Times, Stern, Geo e Le Monde.
Questa volta però, non ha dovuto uscire dal suo Paese di origine: “Locked in Beauty” è infatti un progetto che racconta il lockdown attraverso i luoghi della cultura italiana, vuoti e deserti.

Intervista a Gabriele Galimberti
Come avete vissuto la vostra avventura nella bellezza diventata inaccessibile?
Come un viaggio irreale. La commissione è arrivata a me e a Paolo da Antonio Carloni, direttore del festival di visual narrative di Cortona, con l’intento di alimentare The Covid-19 Visual Project. L’obbiettivo era quello di alimentare l’archivio delle testimonianze visive sui diversi aspetti della pandemia da coronavirus: gli effetti, i sacrifici, i barlumi di speranza.
In pieno lockdown, a noi è stato riservato il privilegio di visitare i grandi musei italiani chiusi e inaccessibili al pubblico. La sfida è stata quella di mostrare la crisi e le implicazioni sociali di questa crisi nella bellezza. Questo per restituire una nuova luce alle opere d’arte e tirarle fuori dall’oscurità e dal silenzio in cui erano immerse.
Dal Museo Archeologico di Napoli fino all’Accademia di Firenze, abbiamo trascorso 10 ore da soli dentro ogni museo deciso ad aderire alla causa, accompagnati solo dai custodi. Il risultato è stata la selezione di una ventina di foto, di cui 4 esposte a Cortona On The Move.


Quali sono state le difficoltà nel realizzare la raccolta, che avete poi chiamato “Locked in Beauty”?
L’obbiettivo non era tanto mostrare come appaiono i musei vuoti e deserti: questi ambienti sono infatti vuoti anche di notte. Il concetto da trasmettere era molto più sottile. Dovevamo rappresentare l’assenza.
Penso sia stata questa la maggiore difficoltà, trovare una chiave di lettura che potesse esprimere la mancanza dei visitatori. Sono loro il cuore pulsante di queste realtà che sopravvive grazie ai suoi appassionati: senza, cessa la loro ragione di esistere.


Da qui, quindi, deriva la scelta artistica di inserire l’ombra, che effettivamente può esser vista come il ricordo di una presenza: conserva delle persone la fattezza, ma non l’identità.
Sì, mentre visitavamo i musei ci è venuta l’idea di come lasciare traccia di elementi umani allora assenti.
Abbiamo ideato giochi di luce per illuminare e nascondere elementi. Con le ombre siamo riusciti a raccontare l’assenza. Per proiettarle io e Paolo inizialmente ci siamo usati a vicenda, fino ad impiegare anche statue dei musei in cui ci trovavamo. Abbiamo anche trovato il modo di rappresentare i musei in modo diverso, impiegando le sagome degli stessi custodi, che quei luoghi alla fine non li hanno mai abbandonati. In questo modo abbiamo evitato che le nostre foto diventassero solo immagini di sale deserte.




Quale dei tuoi altri progetti in cui hai raccontato il Covid-19 senti più tuo?
Prima del lockdown, mi era stato commissionato un lavoro nel Filippine da National Geographic. L‘impossibilità data dalla pandemia di poter viaggiare mi ha impossibilitato a partire. Bloccato a Milano, mi sono proposto alla rivista per raccontare ciò che stava succedendo qui, visto che mi trovavo in una delle prime città ad essere colpite dal virus.
In redazione si sono mostrati subito interessati, quindi ho iniziato subito a pensare a come raccontarlo. La prima sensazione visiva, un po’ per tutti, è stata quella di riprendere le piazze e i quartieri vuoti. Questo perché è stato il primo forte cambiamento ad esser stato percepito. Assistere ad una Milano deserta era senz’altro di grande impatto.
Ma io essendo di base un ritrattista, quando rivedevo le foto non mi sentivo soddisfatto. Volevo parlarne con qualcuno e confrontarmi per capire il perché. Per questo ho proposto ad un mio caro amico di incontrarci, ma dall’altra parte ho avvertito tanta paura al contatto.
Forse è stato quello il momento in cui ho percepito veramente il distanziamento sociale, insieme a quello che stava succedendo e cambiando. Fino ad allora non avevo provato nemmeno il confinamento in casa. Rispetto ad altri, potevo muovermi in città, nonostante gli spostamenti fossero limitati. Come giornalista e grazie al contratto con National Geographic non ho avuto problemi e non sono mai stato fermato.
Mi è venuto a quel punto in mente di chiedere ad una mia cara amica, la quale viveva al primo piano, di affacciarsi alla finestra. Io la aspettavo nel cortile sottostante per scambiare anche solo due parole. Quella scena mi ha colpito molto nella sua stranezza, e ho chiesto se potevo immortalarla. In quel momento, ho avuto l’idea della serie fotografica di persone in quarantena viste dalla finestra. Successivamente, ho fatto una ricerca per trovare persone in diverse situazioni di vita e isolamento.
Ho sentito fin da subito il lavoro mio, perché esprimeva ciò che avevo vissuto. Ho volutamente scelto di non fare scatti “rubati”, ma posati: i soggetti sono stati sempre rappresentati frontalmente e nei loro ambienti. In questo modo, ciascuno di loro mi ha raccontato in modo chiaro e consapevole come stava vivendo quel momento particolare.
Per costruire il set ho chiesto la collaborazione attiva degli stessi soggetti. Non potendo entrare in casa e scegliere liberamente luci e posizioni, scattare è stato complicato. Ho dovuto prendere le luci, sterilizzarle, passarle attraverso le finestre, indicare ai soggetti dove posizionarle e come usarle.
Ho dato quindi vita ad “Inside Out”, il nome che ho dato a questa raccolta, fotografando le persone in quarantena senza incontrarle, se non attraverso le loro finestre, le vere cornici dei loro mondi ridimensionati.




Vuoi saperne di più sul lavoro svolto a questo evento? Contattami utilizzando la form in questa pagina.